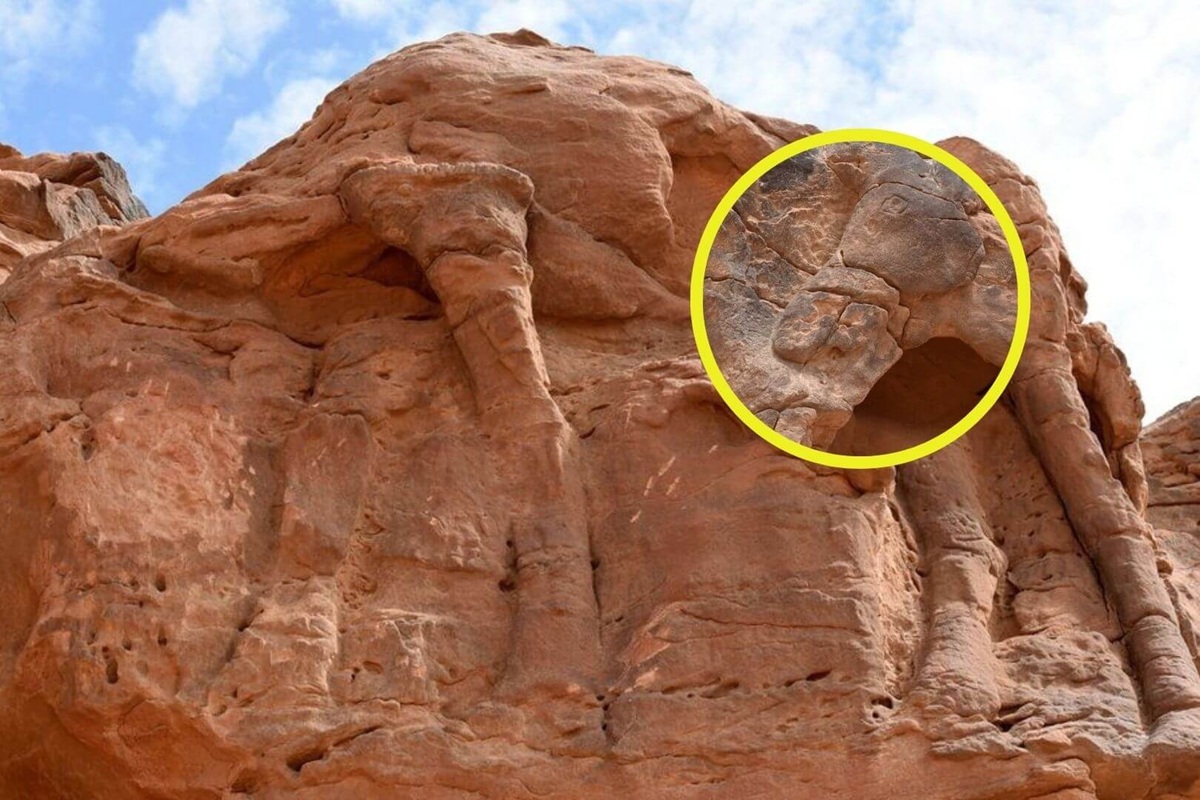Un team internazionale di ricercatori è riuscito a datare con maggiore precisione uno dei fossili più enigmatici d’Europa: il cranio umano rinvenuto nella grotta di Petralona, nel nord della Grecia. Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Human Evolution, il reperto ha un’età minima di 286.000 anni, che lo colloca nel pieno Pleistocene medio e rafforza l’ipotesi della coesistenza di diversi lignaggi umani nel continente.
Oggetto di studio e dibattito per 65 anni

Il cranio di Petralona è stato scoperto nel 1960 e da allora è stato oggetto di intense discussioni scientifiche. La sua posizione stratigrafica non è mai stata chiarita, rendendo difficile una datazione precisa. Nel corso di oltre sei decenni sono state proposte età che oscillavano tra i 170.000 e i 700.000 anni, senza che si raggiungesse un consenso. La nuova analisi, basata sulla datazione mediante serie di uranio del calcite aderente direttamente al fossile, fornisce per la prima volta una cifra affidabile che riduce notevolmente l’incertezza.
Gli autori dello studio, guidati dall’Institut de Paléontologie Humaine di Parigi e con la partecipazione dell’Università Normale di Nanchino (Cina) e del Museo di Storia Naturale di Londra, hanno lavorato su campioni di calcite che ricoprivano il cranio. Il risultato principale stabilisce un’età minima di 286.000 anni, che colloca il fossile in un periodo temporale chiave per l’evoluzione umana in Europa.
Non corrisponde né all’Homo sapiens né ai Neanderthal
Dal punto di vista morfologico, il cranio di Petralona non corrisponde né all’Homo sapiens né ai Neanderthal, ma è associato a un gruppo più primitivo. Il suo aspetto ricorda il famoso cranio di Kabwe, trovato in Zambia, con cui condivide alcune caratteristiche e che viene solitamente incluso nell’ampio insieme di fossili attribuiti all’Homo heidelbergensis. I ricercatori sottolineano che entrambi potrebbero rappresentare popolazioni correlate che sono sopravvissute parallelamente alla comparsa dei Neanderthal.
Il lavoro affronta anche la controversia sull’esatta ubicazione del fossile all’interno della grotta. Sebbene per decenni si sia ipotizzato che fosse cementato a una parete del cosiddetto Mausoleo, le nuove datazioni dimostrano che il calcite del cranio e quello della parete appartengono a fasi diverse. Ciò suggerisce che il cranio potrebbe essere arrivato nella cavità in un momento successivo, tra circa 410.000 e 277.000 anni fa, il che complica ulteriormente la ricostruzione della sua storia geologica.
Convivenza tra popolazioni e scenario evolutivo complesso

L’importanza della scoperta risiede nel fatto che conferma la diversità degli ominidi, una sottotribù di primati ominidi caratterizzati dalla postura eretta e dalla locomozione bipede, in Europa durante il Pleistocene medio. Secondo lo studio, gruppi legati all’Homo heidelbergensis coesistevano con popolazioni che mostravano già tratti neandertaliani. Questa coesistenza, documentata anche in siti in Francia, Italia e Spagna, suggerisce uno scenario evolutivo complesso, in cui diversi lignaggi condividevano il territorio e forse interagivano tra loro.