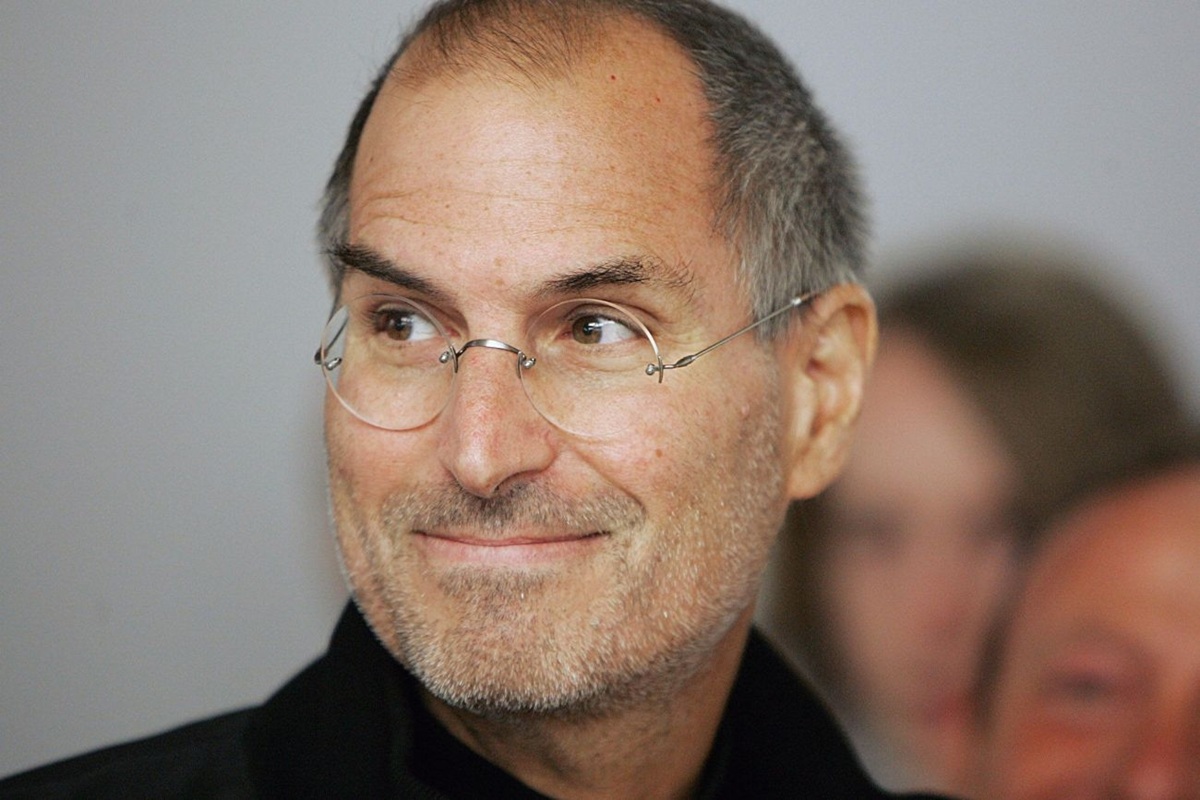Le abilità sociali si sviluppano a partire dal linguaggio. Ma non solo dal linguaggio parlato, bensì anche dal linguaggio corporeo, dal tono, dal contesto e dalla capacità di comprendere segnali sociali complessi. Fin dai primi anni di vita, lo sviluppo comunicativo e socio-emotivo si forma sulla base dell’ambiente linguistico, in particolare della quantità e della qualità degli scambi conversazionali.
Perché una persona che risponde con monosillabi o frasi brevi è priva di abilità sociali?

Le abilità sociali sono l’insieme delle capacità necessarie per interagire adeguatamente con gli altri. Queste includono:
- Comprensione delle norme sociali.
- Uso del linguaggio verbale e non verbale.
- Empatia e riconoscimento delle emozioni.
- Ascolto attivo e reciprocità conversazionale.
Quando una persona dà risposte molto brevi o evita di intrattenere conversazioni fluide, è possibile che presenti deficit in una o più di queste aree.
Secondo la ricerca Language and socioemotional development in early childhood: The role of conversational turns (Gómez e Strasser, 2021), la frequenza con cui i bambini piccoli sono coinvolti in scambi comunicativi con gli adulti predice il loro successivo sviluppo socio-emotivo. In altre parole, un minor numero di turni conversazionali durante l’infanzia si traduce in minori competenze sociali in età adulta.
Ciò è legato a un’idea centrale: la capacità di sostenere una conversazione non nasce spontaneamente, ma si apprende, si allena e si sviluppa nel tempo.
Segnali precoci e contesti associati alle difficoltà comunicative
Nel documento Speech-language-communication needs in youth mental health, di Orygen (un’organizzazione australiana leader a livello mondiale nella salute mentale dei giovani) si identifica che certi comportamenti nell’adolescenza e nella gioventù possono essere erroneamente interpretati come disinteresse o atteggiamento, quando in realtà si tratta di segnali di difficoltà comunicative. Tra questi segnali spiccano:
- Uso ricorrente di risposte monosillabiche.
- Difficoltà a mantenere l’attenzione durante una conversazione.
- Evitare il contatto visivo.
- Comportamento fisico chiuso o difensivo.
Questo tipo di manifestazioni non solo influisce sullo sviluppo interpersonale, ma ha anche un impatto sulla salute mentale e sul rendimento scolastico o lavorativo. L’evidenza mostra che molte di queste persone possono avere una storia di disturbi del linguaggio, difficoltà cognitive o mancanza di adeguata stimolazione linguistica durante la crescita.
In contesti come la scuola o il lavoro, la mancanza di abilità sociali può portare all’isolamento, alla bassa autostima o a interpretazioni errate da parte degli altri.
Individuare e comprendere le difficoltà nelle abilità sociali consente di intervenire in modo tempestivo e adeguato. Alcune strategie utili includono:
- Valutazione da parte di professionisti del linguaggio o psicologi.
- Partecipazione a workshop di comunicazione o abilità sociali.
- Sostegno nell’ambiente educativo e familiare.
- Uso di strumenti visivi o alternativi per facilitare il dialogo.
Come esposto nella relazione clinica sui giovani con esigenze comunicative, molti adolescenti sono in grado di nascondere le loro difficoltà con un’apparenza superficiale di normalità verbale. Ma questi limiti vengono alla luce quando sono richieste interazioni più complesse, come spiegare emozioni, discutere idee o risolvere conflitti.
Il rapporto tra comunicazione e salute mentale

Diversi studi mostrano una relazione diretta tra i problemi di comunicazione e la salute mentale. Le persone con difficoltà nelle abilità sociali presentano indici più elevati di ansia, depressione e bassa autoefficacia. In molti casi, questi problemi si rafforzano a vicenda:
- L’ansia sociale può portare ad evitare interazioni prolungate.
- L’evitamento rafforza la mancanza di pratica conversazionale.
- La mancanza di pratica limita lo sviluppo comunicativo.
Inoltre, le risposte brevi o monosillabiche possono essere utilizzate come strategia di autoprotezione in contesti sociali percepiti come minacciosi. Questo comportamento, lungi dall’essere un semplice tratto caratteriale, può indicare la necessità di un intervento o di un sostegno specifico.
Si tratta sempre di mancanza di abilità sociali?
Non in tutti i casi una risposta breve implica una carenza. È importante tenere conto di altri fattori:
- Contesto culturale: alcune culture apprezzano il silenzio o le risposte laconiche come segno di rispetto o riservatezza.
- Stati emotivi specifici: la stanchezza, la tristezza o lo stress possono ridurre la disponibilità a conversare.
- Tratti della personalità: le persone introverse o più riservate possono preferire esprimersi in modo conciso senza che ciò implichi una difficoltà sociale.
Tuttavia, quando questo modello si ripete in modo sistematico, e soprattutto se interferisce con lo sviluppo personale o le relazioni interpersonali, può essere indicativo della necessità di un’attenzione specialistica.