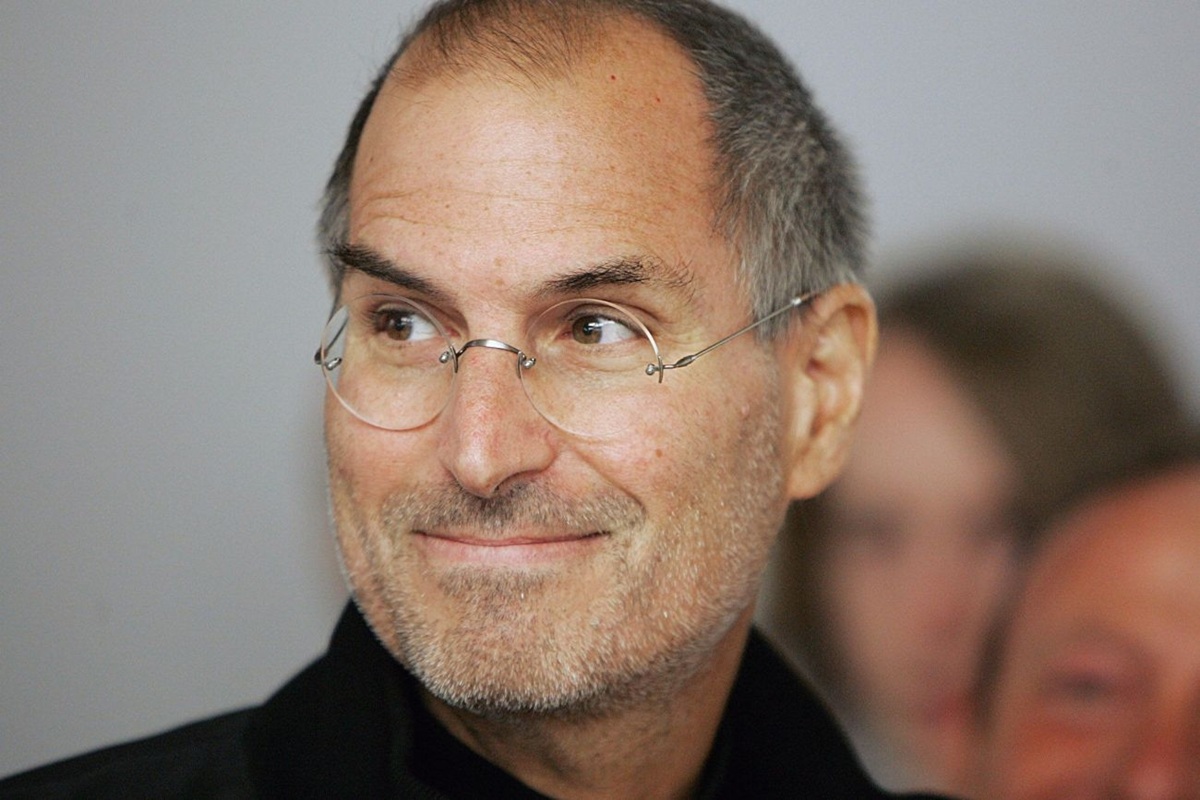La dott.ssa Lucía Crivelli, neuropsicologa e editorialista di, ha offerto oggi una visione rinnovata della felicità, sottolineando il ruolo fondamentale dei neurotrasmettitori, l’importanza dello scopo vitale e come piccole azioni quotidiane possano avere un impatto significativo sul benessere. “L’aspettativa genera felicità di per sé e aspettarsi qualcosa di positivo a volte ci rende più felici del fatto stesso”.
Una scienziata ha spiegato come “potenziare” quattro ormoni del benessere

Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un dialogo, durante il programma del mattino, condotto da Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet e María Eugenia Duffard. In quella sede, Crivelli ha approfondito gli aspetti biologici della felicità e ha sfatato alcuni miti, fornendo al contempo strumenti concreti affinché le persone possano “coltivare” la felicità giorno dopo giorno e dare un nuovo significato alla ricerca del senso personale.
Nel corso dell’intervista, Crivelli ha spiegato che la felicità è stata oggetto di studio fin dall’antichità, ma che, grazie ai progressi scientifici, oggi viene intesa da un punto di vista multidisciplinare. “La felicità è stata studiata dai tempi dei Greci fino ad oggi. L’idea è quella di considerarla dal punto di vista della biologia e delle neuroscienze, in particolare per capire cosa possiamo fare oggettivamente per modificare quei neurotrasmettitori che modulano la felicità”, ha affermato. Ha parlato delle principali molecole responsabili del benessere, identificando la dopamina, la serotonina, l’ossitocina e le endorfine come fattori chiave del nostro stato d’animo.
“La dopamina si attiva quando proviamo gratificazione, ad esempio quando gustiamo un cioccolatino, ma anche quando raggiungiamo un obiettivo che ci eravamo prefissati”, ha sottolineato. “Non è negativa di per sé, nonostante la cattiva pubblicità legata ai social media e alla costante ricerca di questo tipo di ricompense istantanee”, ha sottolineato.
Riferendosi alla serotonina, Crivelli l’ha definita il neurotrasmettitore del “benessere e della calma”. Ha spiegato che la sua produzione può essere potenziata naturalmente attraverso alimenti ricchi di triptofano, come il cioccolato, e attraverso l’esposizione alla luce solare. “È stato studiato che stare al sole la mattina presto, tra i quindici e i trenta minuti, stabilizza l’umore e aumenta il benessere”, ha spiegato. Ha anche raccomandato di evitare luci artificiali intense durante la notte, in particolare la luce blu degli schermi, poiché “cospira contro la felicità influenzando la produzione di melatonina, che è fondamentale per un buon sonno”.
Un altro aspetto centrale che ha affrontato è stato il rapporto tra i legami affettivi e l’ossitocina, nota come l’“ormone dell’amore”. “Abbracciare qualcuno, allattare o anche avere un contatto visivo e fisico con gli animali domestici aumenta notevolmente i livelli di ossitocina. Ad esempio, abbracciare un cane aumenta fino al 300% i livelli negli esseri umani, mentre accarezzare un gatto li aumenta del 130%”, ha precisato. Ha sostenuto che il contatto con i mammiferi, in generale, favorisce il rilascio di questo ormone, generando legami e piacere simili a quelli provati quando si condivide l’affetto con i figli.
Una delle domande poste dai conduttori è stata se la felicità possa essere allenata nella vita quotidiana. A questo proposito, la specialista è stata chiara: “Più che allenare la felicità, si possono implementare abitudini e piccoli accorgimenti che ne favoriscono la comparsa. Mangiare cioccolato, prendere il sole, avere animali domestici, abbracciare i propri cari e fare esercizio fisico sono attività che attivano diversi sistemi di ricompensa e piacere a livello neurobiologico”.
In un dialogo con Infobae en Vivo, nel programma del mattino, la giornalista ha fatto una distinzione fondamentale tra due tipi di felicità: quella edonistica e quella eudaimonica. La prima, associata al piacere quotidiano, è legata ai piccoli piaceri e al benessere del qui e ora. La seconda, invece, si basa sulla ricerca di uno scopo e di un senso profondo della vita. “La felicità eudaimonica – il termine è aristotelico – implica la scoperta di uno scopo vitale. Non servono grandi imprese; il senso può essere raggiunto nella quotidianità, risolvendo i problemi degli altri o godendo di un mestiere“, ha precisato, elencando come i fattori vocazionali e l’impegno per una causa diano una ”grande ricompensa” esistenziale, differenziandosi dal mero godimento istantaneo.
Nel corso della conversazione è stata sottolineata l’influenza del pensiero ottimista e dell’aspettativa positiva come motori, anche in condizioni avverse. Crivelli ha citato il famoso esempio del neurologo Víctor Frankl nei campi di concentramento nazisti, sottolineando che la speranza e la motivazione a raggiungere un obiettivo erano fattori predittivi di sopravvivenza e benessere, al di là della costituzione fisica. “L’aspettativa che accada qualcosa di buono può essere più soddisfacente del fatto stesso. Questo effetto paradossale è sempre più studiato in psicologia e nelle neuroscienze”, ha sottolineato.
La neuroplasticità della felicità: gli scienziati hanno spiegato come il cervello impara a essere felice
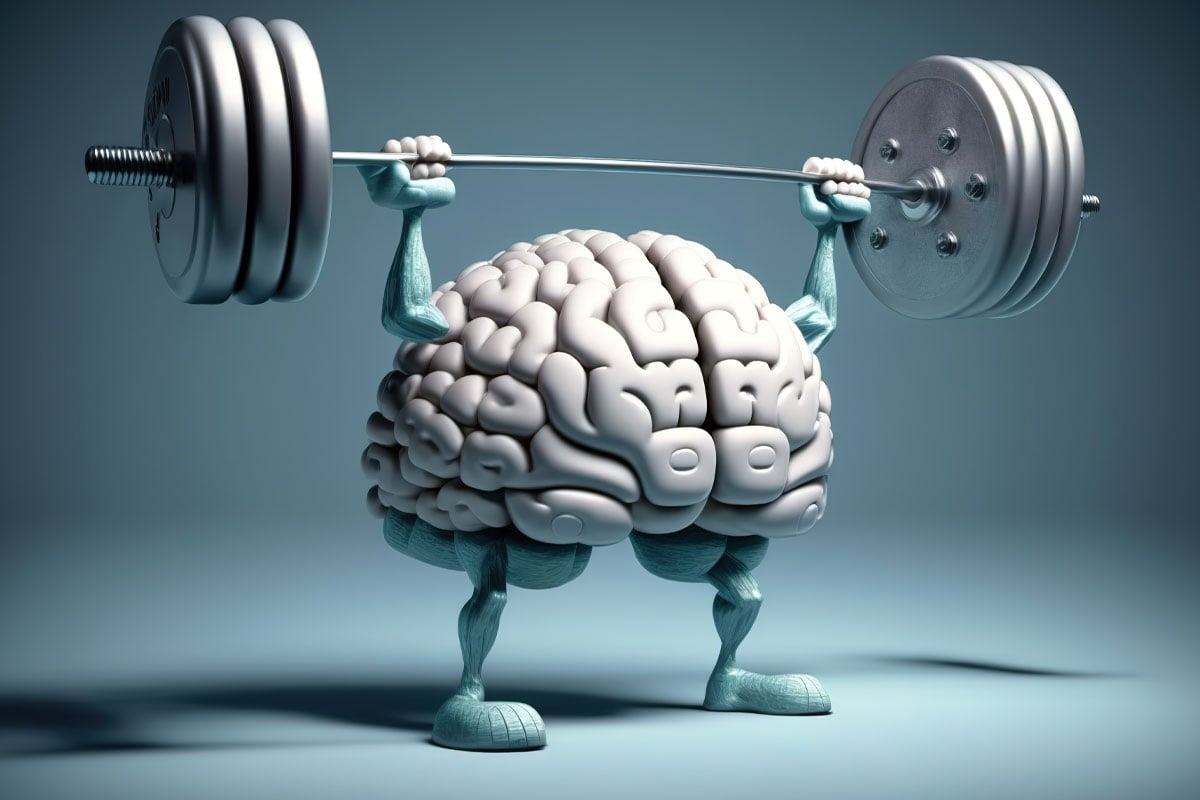
Analizzando come si sostengono e si riconfigurano i “percorsi” cerebrali della felicità, l’esperta ha chiarito che la capacità di cambiamento del cervello — la neuroplasticità — permette di apprendere e rafforzare abitudini sane e pensieri positivi, ma ha precisato che “non si tratta solo di volontarismo; sono necessarie condizioni ambientali adeguate, legami e un ambiente di sostegno”.
Non ha eluso la questione del denaro e della soddisfazione personale: “Lo psicologo Daniel Kahneman lo ha studiato empiricamente e ha scoperto che esiste una soglia economica necessaria per coprire non solo i bisogni primari, ma anche quelli culturali e sociali. Superato tale parametro, un reddito più elevato non aumenta più il benessere soggettivo”, ha precisato.
L’articolo ha anche approfondito la “curva della felicità” che descrive come varia il benessere nel corso della vita. “Il picco di felicità si verifica solitamente tra i 25 e i 35 anni, una fase in cui le persone sentono che tutto è ancora davanti a loro: studiano, si innamorano e crescono. Il periodo tra i 35 e i 50 anni, invece, è caratterizzato da stress e confronti. Oltre i 50 anni, la curva risale: c’è più tempo, più accettazione, più gratitudine“, ha riferito. Ha aggiunto che, secondo alcune ricerche, chi non ha figli nella mezza età mostra livelli di felicità più elevati, ”perché ha più tempo per dedicarsi ad attività che generano piacere e benessere, come l’esercizio fisico, la vita all’aria aperta o i viaggi”.
Ha inoltre esplorato le trasformazioni che comporta l’invecchiamento: “Con l’avanzare dell’età, aumenta la tendenza a sperimentare più ossitocina attraverso atti di generosità e altruismo. Dare genera più piacere che ricevere, cosa che si intensifica nella terza età”.
Durante la conversazione, gli altri editorialisti hanno contribuito con esperienze personali e hanno chiesto consigli su modi pratici per incorporare queste abitudini. Crivelli ha ribadito l’importanza di cercare un equilibrio tra fattori edonistici ed eudaimonici, di valorizzare il processo piuttosto che il risultato e di non fossilizzarsi sul confronto con gli altri. “La felicità ha diverse componenti: piacere, soddisfazione e scopo. La soddisfazione è un bersaglio mobile, che ci sfugge continuamente. Ma è proprio questa dinamica che dà energia alla vita”, ha sottolineato.
Di fronte alla preoccupazione che questo “bersaglio mobile” potesse risultare più stressante che piacevole, Crivelli ha affermato che i meccanismi biologici alla base dei neurotrasmettitori della felicità provocano esattamente l’effetto opposto: riducono i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. “L’ossitocina abbassa il cortisolo e questo circolo virtuoso è fondamentale per il benessere”, ha sottolineato.
Infine, ha sottolineato che godersi il presente non annulla il desiderio di cercare nuovi orizzonti né l’importanza di godersi il processo. “Le aspettative e i progetti sono parte del presente. Godersi ciò che è già stato raggiunto e allo stesso tempo avere nuovi desideri sono processi complementari”, ha sottolineato, avvertendo che “non si tratta solo di soddisfare i piaceri materiali, ma di perseguire scopi vitali”.